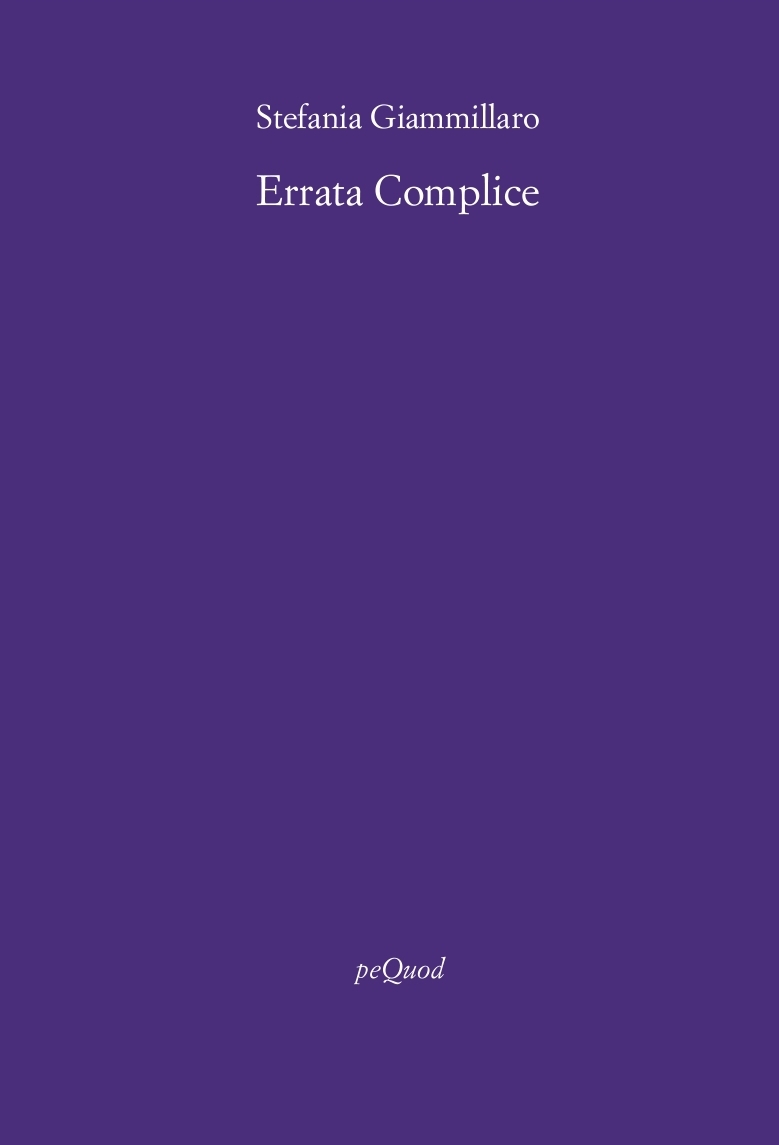Accorgersi di amare troppo. Su Errata complice di Stefania Giammillaro
Alludendo alla locuzione latina ma completandola in modo inatteso e così immediatamente accusatorio, il titolo della raccolta innesca una oscillazione semantica decisamente fertile: gli errata, infatti, che come è noto nel lessico tipografico indicano una lista di parole sbagliate, gli errori, richiamano immediata l’idea di una loro pronta e puntuale correzione; e invece qui non si legge corrige ma, enigmatica e terribile, la parola complice. Ed ecco servito il primo calembour, ecco venire in luce, prima ancora di aprirne le pagine, la cifra retorica che caratterizza in modo peculiare le poesie di questo libro: l’allusione, l’ironia, l’ossimoro, il gioco di parole, lo slittamento che spiazzando spingono il lettore a un movimento interpretativo, e quindi a non rimanere sulla soglia, sulla pura superficie delle parole, ma a entrare attivamente nel circolo ermeneutico, e non tanto per uscirne vittorioso con la “chiave” che si suppone giusta, univoca, quanto per restarvi “bene dentro”, come scriveva Heidegger, in ascolto, accorgendosi, come reiteratamente invita a fare Stefania Giammillaro.
A fronte di quanto c’è di sbagliato, quindi, non un imperativo all’emendamento ma la denuncia di una corresponsabilità, di una connivenza: del resto, la ricognizione e l’elencazione delle cose errate non ha un reale corrispettivo di correzioni possibili – la vita non è un testo che si corregge, nessun imperativo vale a risanare strappi, spaccature, morsi, stimmate, non vi è nessuna giustizia, nessun riscatto, nessun risarcimento che non sarebbe – scrive a un certo punto Giammillaro – l’ancorarsi a una mera illusione di passaggio. Sugli strappi, sulle spaccature, si può tornare ma non muovendo all’indietro, semmai procedendo lungo una traiettoria spiraliforme, in cui si torna su uno stesso punto, sì, ma in un altro piano, su un altro livello: su un altro livello di consapevolezza, su un altro livello linguistico, dal quale poter vedere diversamente le cose. E dare loro un nome.
Errata complice è un libro dolente ma che coglie l’io lirico in un percorso evolutivo; è un libro a tratti duro, amaro, ma non astioso; è un libro che duramente dice l’isterilimento dell’io dentro una relazione sbilanciata, di un io che però non si ripiega sterilmente su sé stesso; è, infatti e non da ultimo, un libro che muove da uno spazio intimo, privatissimo, ma che finisce con lo sporgersi su uno spazio politico.
C’è un’istanza etica che si muove parallelamente a un’urgenza testimoniale nel dettato oscuro di questo libro. Uso l’aggettivo oscuro riprendendone il senso duplice offerto da Franca Alaimo nella sua precisa Prefazione: come atmosfera notturna e come impermeabilità semantica. Sembrerebbe una contraddizione: esporsi, voler dare testimonianza, metterci la faccia, senza tuttavia aderire a un’opzione formale di trasparenza; voler assumere una posizione, e pertanto decidere di non tacere, e però usare una lingua criptica, enigmatica, a tratti persino sfuggente.
Ma questo di Stefania Giammillaro non è un saggio né un romanzo. Dalla poesia possiamo bene aspettarci che mostri traslando, che affermi alludendo, che urli, se il caso, sussurrando o addirittura tacendo. Andando a capo quando qualcosa nel discorso si spezza. Affilando la parola fino a farne un filo spinato, sterrandola fino a scavare un solco di trincea, come qui fa Giammillaro, nascondendosi in essa non per guerra e tantomeno per un gioco che culmini in un liberitutti – non so fino a che punto sia stato liberatorio, catartico, scrivere questo libro – nascondersi, si diceva, non per essere trovata, ma semmai per trovarsi lasciando traccia. Per fare di questo groviglio, dato dal ripiegamento in sé, un principio di semina, morte e germinazione, morte di un certo modo di essere e germinazione di un nuovo sé, fioritura in poesia.
Concordo nel ritenere che l’oscurità vada vista come elemento centrale nell’opera che stiamo leggendo e non soltanto come mera cifra stilistica dell’autrice. L’oscurità (ciò che non subito o affatto si comprende, quello che non sempre è immediato, quello che appare privo di logica consequenziale) dice tantissimo del travaglio, del percorso, del processo, cui è sottoposto l’io poetico. Soluzioni o assoluzioni a parte: perché credo che né le une né le altre siano l’obiettivo ultimo di questa scrittura.
Il tema delle relazioni tossiche, come si suole chiamarle oggi, di quell’amore asimmetrico che non è più amore dentro la prigionia dell’asservimento, della violenza psicologica, dell’annientamento, viene qui rappresentato (non raccontato, insisto) come esperienza di un io lirico che non si sottrae alla complessità percorrendo integralmente la complementarità insita in tutte le relazioni, per quanto doloroso, per quanto rischioso sia: se c’è infatti una parte prevaricatrice, violenta, annientante, è fatale che vi sia anche una controparte prevaricata, violentata, annientata, ed è su questo versante della relazione che Giammillaro appunta (anche) la sua attenzione, contro la quale punta il dito, individuando una corresponsabilità. È questo un tema spinoso assai: sulla reale o presunta complicità della vittima si è scritto e riflettuto tantissimo, anche allo scopo di evitare che la vittima divenga vittima due volte, accettando le accuse e addirittura autoaccusandosi di una connivenza che invece è sempre tutta da dimostrare. Il rischio, nel richiamare una idea di complicità, è quello di cadere nella trappola più raffinata, di infilare il piede nell’estremo laccio che lega la vittima inducendola ad attribuirsi colpe e responsabilità, innescando il meccanismo perverso che dal fallimento conduce a una perseveranza tossica, all’accanimento.
Ma se non cerca liberazione, né assoluzione, se non millanta ricette risolutorie, è nel campo testimoniale che la poeta si muove, è dicendo, decidendo di non tacere come ci insegna Brecht nella sua paradigmatica poesia politica: non si dirà: i tempi erano oscuri ma: perché i loro poeti hanno taciuto. È nominando le cose per farle esistere che la poesia diviene azione, diviene politica. Errata complice è il rilascio di una dichiarazione spontanea che diviene monito, leva di cambiamento, sostegno, attraverso la nominazione poetica che rende visibili e dicibili le cicatrici che segnano e ancora urgono e che non appartengono (non soltanto) alla dimensione privata: testimoniare un’esperienza legata alla violenza di genere è un dono che si offre alla comunità, un impegno civile.
Aprendo il volumetto non posso fare a meno di soffermarmi sulla frase dedicataria che indirizza la scrittura A chi ama troppo: come non pensare al titolo del famoso saggio di Robin Norwood? Alla fine degli anni ’80, negli Stati Uniti e poco dopo anche da noi in Italia, la psicoanalista americana pubblicò Donne che amano troppo, un lavoro allora pioneristico sul tema, nel quale riportava le esperienze di relazioni tossiche di molte donne, fornendo un quadro interpretativo che assimilava queste relazioni alla dipendenza, una proposta di percorso terapeutico, ma soprattutto dando un nome a una serie di comportamenti che costituivano un quadro ricorrente da lei sintetizzato nell’amare troppo, per l’appunto. È interessante il rilievo che la stessa autrice fa poi, a distanza di anni, sul fatto che aver messo allo scoperto meccanismi e irrazionalità non costituisca, da solo, una leva di cambiamento, mentre invece insiste in un punto: l’importanza della cura della spiritualità, in qualunque modalità sia intesa, non ultima la religiosità che sempre Alaimo, in Prefazione, rintraccia all’apice del percorso tracciato da queste poesie, spiritualità che Robin Norwood mette in connessione con un diverso modo di intendere l’attenzione e la cura di sé, incluse la meditazione e la preghiera. (Robin Norwood, Donne che amano troppo, Feltrinelli 1989, traduzione di Enrica Bertoni).
Se una strada ci indica il libro di Stefania Giammillaro, direi che è proprio questa: se non risana, se non pareggia i conti, se non riscatta, la poesia è cura di sé, lavoro dello spirito per lo spirito, specchio per il dolore nel tragitto verso la riconciliazione con sé stessi e la rinascita.
(…)
La parola è ponte che attraversa
La possibilità di perdonarmi
Allo specchio dei rimorsi
E se sanguino
Sanguinerò per partorirmi
(pag. 60)
E di questa strada vi è segno non soltanto nel contenuto della poesia di questo libro ma anche nei suoi aspetti formali. Come dicevo, è possibile rintracciare i segni di una ricerca in questa direzione, una corrispondenza inestricabile del tema e del modo di darne espressione. La frequente presenza di personalizzazioni, per esempio, (le perplessità viaggiano, le soglie attendono, i ritardi scappano, gli anfratti sono piegati dalla stanchezza, il vuoto è nominato con la maiuscola) che traslano i sentimenti dell’io poetico sugli oggetti, così come d’altro lato, il rivolgersi a un tu che sovente coincide con uno sdoppiamento dell’io poetico, sono spie di un tentativo di distanziamento necessario a una più adeguata messa a fuoco. La vista, non a caso, è la sfera sensoriale richiamata in una esortazione ad accorgersi, a guardare, a voler vedere. Accorgersi, oltrepassando la triste eredità di una vista appannata (come nel testo di p.17). E d’altra parte, l’essere visti interi, oltre la dimensione estetica, al di qua del pregiudizio.
Non da ultimo, e sempre restando in tema di scelte formali, mi sia concessa una considerazione sul ricorso al dialetto, che qui sembra marcare i passaggi, i nodi cruciali nell’evolversi di questo rapporto tra il vedere e l’essere guardati, tra la cecità dell’io lirico e la sua opacità: l’uso del dialetto appare tanto più interessante se connesso a un gesto di rottura che ancora una volta si realizza su un piano linguistico, nella ricerca di parole vere, per dirla con Ingeborg Bachman, ruvide abbastanza da lasciare un segno, talmente antiche da essere nuove nella pronuncia di una poeta giovane come lo è Giammillaro, che col dialetto “sporca” la politezza remissiva del discorso e dà alla voce una lingua di parole non usurate, non banalizzate dalla levigatezza appannata che adultera la verità e conduce all’errore.
Il confronto tra testo in dialetto e traduzione, negli ultimi versi della poesia di pagina 64, è illuminante e per certi versi paradigmatico, trasposizione in poesia di una dinamica tipica delle relazioni tossiche: la carezzevole resa in lingua italiana del verso “ru cori/ nun c’è chiù nenti ri pigghiari” (che letteralmente sarebbe “dal cuore/ non c’è più nulla da prendere”), nell’autotraduzione diviene “il cuore / non ha più nulla da donare”, finendo con il capovolgere la direzione del movimento, e sostituendo con la desolazione “colpevole” di non poter ancora dare, quello che di fatto è l’esito di uno svuotamento, di un gesto abusante che ha preso, e preso, e preso, fino a prosciugare totalmente l’io.
Patrizia Sardisco
Provo ad indovinare il tuo amore
in un gioco di scatole cinesi
senza nome
“Sgranare il rosario dei misteri”
– dici –
ma non si sciolgono ghiacciai
appesi al tiro del tuo arco
stalattiti di marmo
mano nella mano con te.
Non più una sfida scorgo
ereditando il lascito di
una vista appannata
*
Nulla è perduto
tutto è adesso
Non sono viva nel ricordo
nell’ossessione
di quel che avrei potuto
La carne è in questo pizzicotto
che giro di traverso per sentirmi
quando non distrae il mare
La parola è ponte che attraversa
la possibilità di perdonarmi
allo specchio dei rimorsi
E se sanguino
sanguinerò per partorirmi
*
Muta sugnu
comu pisci senza sangu
ca trema a schina ghigata
Littra strazzata
pi na lisca lissata
n’mezzu ai renti
Sula, sittata
ravanti a tavula cunzata
cu tutti i cumannamenti
Figghia sugnu
e matri mi ciamu
senza iabbu né maravigghia pi parenti
senza patiri i dulura
ra nascita
m’arricampu cunzumata
pi chiddi ra morti
sorti mavara
ca m’accumpagna
Matri sugnu
e figghia nasciu n’autra vota
pi vuatri ca nun cririti a na parola rata
surda e malacavata…
Nun viru nun parru nun sientu
ma vi lassu a testamento
na cunnanna
na ninna nanna d’amuri
ca comu sciroccu
ciusciando rina, vi ricuorda:
“L’uocci aggiuvanu a taliari
sulu quannu ru cori
nun c’è chiù nenti ri pigghiari”.
Muta sono / come pesce senza sangue / che trema a schiena piegata / Lettera strappata / per una lisca lasciata / tra i denti // Sola, seduta / davanti alla tavola apparecchiata / con tutti i sacramenti (apparecchiata a puntino) // Figlia sono / e madre mi chiamo / senza stupore né meraviglia per i parenti / senza patire i travagli del parto / vi raggiungo consumata per quello della morte / sorte cattiva / che m’accompagna // Madre sono / e figlia nasco un’altra volta / per voi altri che non credete alla parola data / sorda e malfatta… / Non vedo, non parlo, non sento / ma vi lascio a testamento / una condanna // una ninna nanna d’amore / che come scirocco / soffiando sabbia, vi ricorda: / “Gli occhi servono a guardare / solo quando il cuore / non ha più nulla da donare”.
https://www.italicpequod.it/books/errata-complice/
Scopri di più da larosainpiu
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.